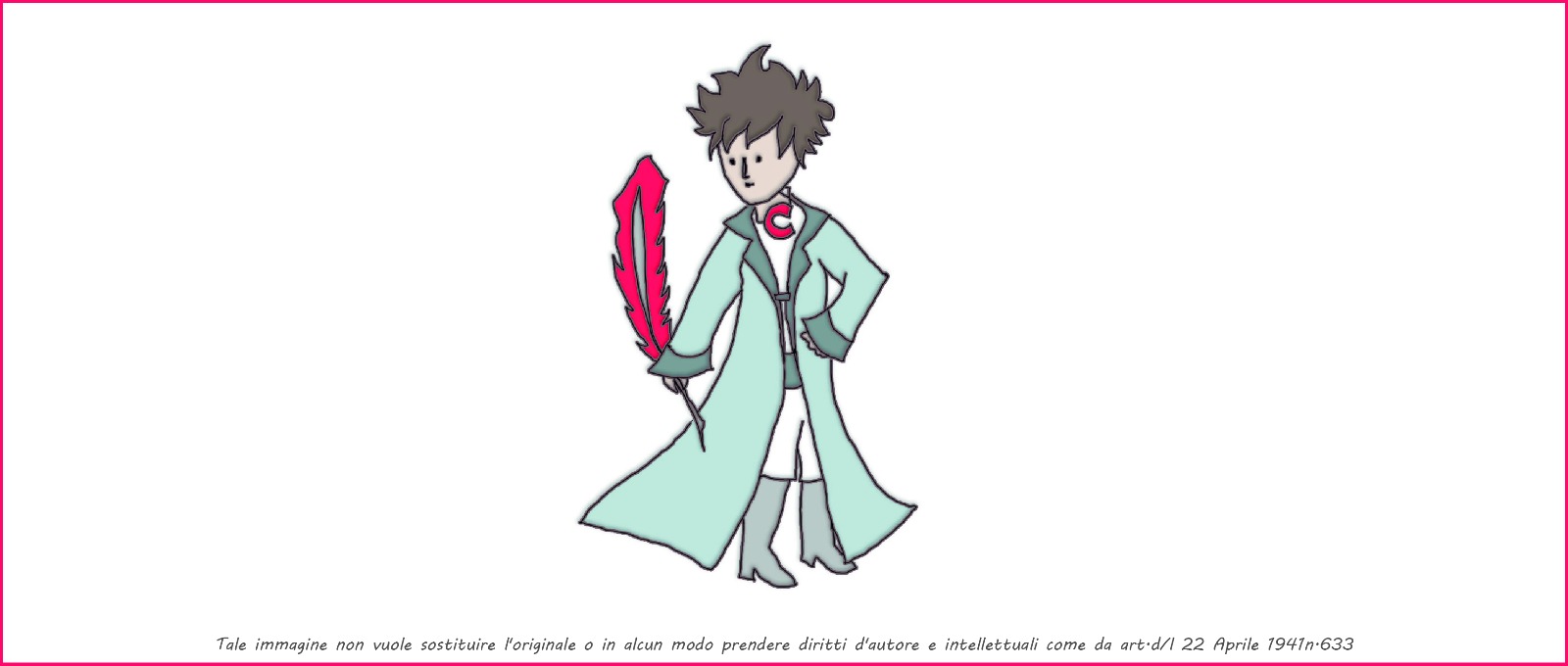UPEstate
Pietro Bartolo, il cinema che cura l'anima
di Chiara Lenzi
“L’umanità è come un unico corpo se una parte è sofferente, anche il resto del corpo non può stare bene”
(Pietro Bartolo – medico di Lampedusa)
L’umanità è fatta di singoli Uomini e Donne, ognuno con una storia, le proprie sofferenze, le proprie paure, dolori, tragedie, gioie… Mi è sempre piaciuto ascoltare le persone, le loro storie, osservarle mentre sono sedute su un autobus o guardano una vetrina e immaginare le loro vite.
Da quando frequento i corsi di UPE e CB (Counseling Bioenergetica) è iniziato un meraviglioso viaggio nell’uomo, partendo da me e i miei compagni di corso. Ascoltare la Storia di ognuno è un dono prezioso di crescita. Siamo essere meravigliosi, ognuno è un essere meraviglioso, un’opera d’arte e più conosco le persone, più mi convinco di questo.
Mi direte ma tutto questo cosa c’entra col cinema che è il tema su cui dovrei scrivere? Al cinema si conoscono storie, di fantasia, di vita vera, si entra nella vita dei personaggi, come a farla propria… In due ore si può percorrere una vita intera, le sue emozioni, paure, gioie…
Con il genere documentario (quando è distribuito in sala, e non avviene spesso, consiglio di andare a vedere) si può viaggiare, conoscere luoghi dove non saremmo mai potuti andare per mancanza di tempo e denaro, storie di persone che si raccontano a noi, che non avremmo mai avuto modo di conoscere nella nostra vita, o aspetti di un luogo conosciuto che non avevamo visto. Come in un condensato di vita.
Questa primavera vidi in sala “Visages Villages” di Angés Varda e JR, che mi ha stregato: il viaggio nella provincia francese di una strana coppia, lei regista ottantenne che sta perdendo la vista, lui giovane fotografo che non toglie mai gli occhiali da sole. Un viaggio lento tra villaggi, visi, storie del passato e del presente… Storie di lavori, amori, amicizia. Di amicizie che durano una vita o pochi minuti. Dove ci si racconta e mette a nudo anche attraverso la fotografia o ci si protegge dietro a un paio di occhiali…
In queste giornate estive, di mare, sole, relax, irrompe nelle nostre vite una realtà molto diversa, diciamo che nonostante i nostri problemi, siamo una parte del corpo umanità che sta bene, circondato da parti sofferenti (facendo un censimento le parti nel mondo senza guerre, carestie, dittature sono la minor parte, decisamente troppo poche).
Mi ritornano in mente gli occhi dolci, sofferenti, combattivi e coraggiosi di Pietro Bartolo che conobbi prima sullo schermo grazie a Fuocoammare di Gianfranco Rosi e che poi ebbi l’onore di conoscere di persona. Chi è Pietro Bartolo? Lo definirei un eroe dei nostri giorni, lui si definisce un uomo, che semplicemente fa il suo dovere di medico, quello di curare vite umane. Ma non è solo questo visto che è nato e vive a Lampedusa, terra di sbarchi come la cronaca ci fa vedere. Quello che la cronaca non ci restituisce è l’Uomo, il suo “esserci”, il suo non arrendersi mai. Bartolo che ti accoglie col sorriso, una pacca sulle spalle, un abbraccio e le sue storie, un fiume in piena che racconta delle centinaia di vite che arrivano dal mare al porto dell’isola, che per lui sono ognuna un Nome e un Cognome, una Storia di vita. Ti racconta la storia di ognuno, come fosse quella di un fratello, di un nipote, un cugino, un pezzo di famiglia che ha vissuto tragedie inenarrabili, ma che rimangono scritte nei loro corpi, negli sguardi, nei silenzi. E non lo lasceresti più.
“A volte penso di non farcela. Di non reggere questi ritmi, ma soprattutto di non reggere tanta sofferenza, tanto dolore. Molti miei colleghi, invece sono convinti che ormai mi ci sia abituato, che fare ispezioni cadaveriche per me sia diventata una routine. Non è così. Non ci si abitua mai ai bambini morti, alle donne decedute dopo aver partorito durante il naufragio, ai loro piccoli attaccati al cordone ombelicale. Non ci si abitua all’oltraggio di tagliare un dito o un orecchio per poter estrarre il DNA, e dare un nome, un’identità a un corpo esanime e non permettere che rimanga un numero. Ogni volta che apri un sacco verde è come fosse la prima volta. Perché in ogni corpo trovi i segni che ti raccontano la tragedia di un viaggio lunghissimo. Spesso si pensa che la difficoltà per i profughi sia solo la traversata in mare. Quella è l’ultima tappa. Ho ascoltato i loro racconti a lungo. La scelta di partire, di lasciare la propria terra. Poi i deserto. Il deserto è l’inferno, dicono, e non lo puoi capire se non ci sei dentro. Poca acqua, stipati sui pick-up, dove se ti siedi nel posto sbagliato sei sbalzato fuori e muori. E quando l’acqua finisce, per sopravvivere puoi bere solo la tua urina. Giungi in Libia, pensi che l’incubo sia finito, e invece ha inizio un altro calvario: la prigione, le torture, le sevizie. Solo se riesci ad affrontare tutto questo, a superare tutte le crudeltà, ti imbarchi. Curare le ferite del corpo è il mio lavoro. Fare il mio meglio per alleviare il dolore. Uno dei miei crucci, però, è quello di non possedere gli strumenti per curare le ferite dell’anima.”